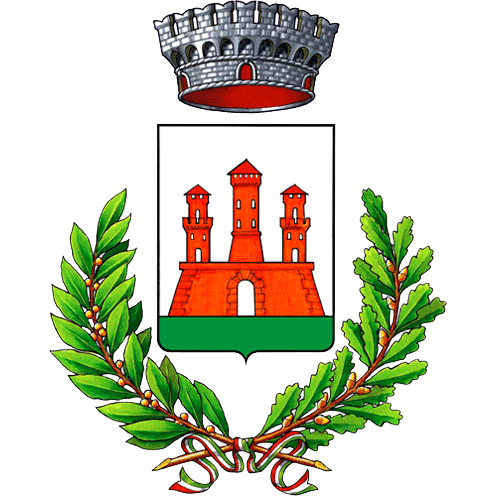Introduzione
Dai documenti storici relativi alla costruzione ottocentesca del giardino risulta che vi fosse molto interesse, da parte dei conti Spalletti Trivelli, di mettere a dimora, nel giardino in corso di realizzazione, specie esotiche rare. Questa era una caratteristica dei giardini paesaggistici (o “all’inglese”) per i quali si cercavano specie provenienti da luoghi lontani per poter ammirare e far ammirare delle vere e proprie rarità botaniche che inducessero sorpresa e meraviglia negli ospiti e dessero notorietà ai proprietari.
Dell’impianto del giardino ottocentesco sono sopravvissuti pochi esemplari arborei, riconducibili, probabilmente, ad alcuni platani e tassi prossimi al palazzo padronale. Le cause di ciò derivano dal fatto che non sempre le piante esotiche si adattano perfettamente alle condizioni pedoclimatiche di luoghi diversi dai loro areali. Inoltre, nel 1944, molti alberi furono abbattuti per evitare i bombardamenti angloamericani che privilegiavano obiettivi boscosi in quanto pensavano che fossero riparo visivo alla ricognizione aerea per mezzi e materiali dell’esercito tedesco. Gli alberi presenti sono in parte riconducibili a successive piantagioni realizzate dai conti Spalletti Trivelli a partire, indicativamente, dagli anni ’50 del Novecento.
1. Aesculus hippocastanum (Ippocastano)
L’ippocastano, albero a foglia caduca dall’abbondante e vistosa fioritura, è l’unica specie del genere Aesculus ad essere originaria dell’Europa. E’ infatti endemico, cioè tipico, dell’area dei Balcani, ed in particolare delle zone montuose dell’Albania, Grecia, Macedonia e di parte della Bulgaria. L’albero fu introdotto in Europa occidentale intorno alla metà del ‘500. Tra i primi a parlarne e a descriverlo si ricorda il medico e naturalista Pietro Andrea Mattioli che all’epoca risiedeva a Praga, il quale, probabilmente, ottenne dei semi (1557) da Willelm Quackelbeen, medico dell’ambasciatore in Turchia dell’imperatore Ferdinando I. Un ulteriore contributo (1561) viene da Ulisse Aldrovandi, famosissimo e importante naturalista, fondatore dell’Orto botanico di Bologna (1568). Il nome di hippocastanum deriva da “Hippos” cioè cavallo e “Kástanon” cioè castagno, in quanto i semi, che ricordano le castagne, pare fossero somministrati in ragione di 3 o 4 alla volta ai cavalli affetti da dolori di petto, in particolare tosse e malattie da vermi. In Italia viene chiamato anche “Castagno d’India” analogamente alla Francia ove assume il nome di “Marronier d’Indie” poichè si pensava, in origine, che l’albero provenisse dall’estremo oriente. Apprezzato per la vistosa e abbondante fioritura fu utilizzato, sotto il regno di Luigi XIV, per creare dei filari e dei boschetti nei giardini delle Tuileries a Parigi e in quello di Versailles dove, nel 1704, furono piantati altri ippocastani nella ristrutturazione della “stanza” degli Antichi, da allora conosciuta come “Salle des Marroniers”. Divenne, anche a causa di ciò, una pianta molto utilizzata nei giardini e lungo i viali.
2. Gleditsia triacanthos (Spino di Giuda, Spinacristi)
Albero a foglia caduca originario dalla zona centrorientale degli Stati Uniti, è una pianta rustica, molto resistente alla salinità e alla siccità, utilizzata nei luoghi d’origine per il controllo dell’erosione e come albero frangivento. Fu introdotta in Europa nel ‘600, mentre in Italia pare sia giunta intorno al 1760-1772. Nell’Ottocento, nel modenese, ne è testimoniato l’uso per realizzare siepi spinose utili a proteggere i giardini dall’ingresso di animali e persone. Il nome del genere è stato attribuito da Linneo in ricordo del botanico tedesco Johann Gottlieb Gleditsh (1714-1786) che fu direttore dell’Orto Botanico di Berlino. L’epiteto specifico invece deriva dal greco “treis” (tre) e “akantha” (spina) e indica il fatto che le vistose spine di cui è dotato a volte possono presentarsi con un aculeo centrale lungo e due aculei laterali più corti.
3. Catalpa bignonioides (Catalpa, Albero dei sigari)
E’ un albero a foglia caduca originario di un areale ristretto degli Stati Uniti, comprensivo di Mississipi centrale, Alabama, Georgia e Florida. Presenta una vistosa fioritura con fiori riuniti in infiorescenza a pannocchia. I frutti sono baccelli stretti e lunghi, molto caratteristici, da cui deriva il nome di Albero dei sigari. Fu introdotta in Europa intorno alla metà del ‘700 come pianta ornamentale, e citata per la prima volta in Italia nel 1760 da Carlo Ludovico Allioni, direttore dell’Orto Botanico di Torino e corrispondente di Linneo, del cui sistema di classificazione fu uno dei primi sostenitori. Il nome del genere deriva da quello datogli dagli indigeni della Carolina (kutuhlpa) e fu istituito nel 1777 dal botanico e naturalista Giovanni Antonio Scopoli, direttore dell’Orto Botanico di Pavia.
4. Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano)
E’ un albero a foglia caduca diffuso, allo stato spontaneo, in un vasto areale che si estende dall’Europa al Caucaso. In Italia è presente, in natura, in tutte le regioni. L’epiteto specifico “platyphyllos” significa letteralmente “foglie ampie”. Nella farmacopea popolare e in erboristeria se ne utilizzano in particolare i fiori essiccati come sedativo, ipnotico, emolliente e sudorifero. I fiori profumati ne hanno fatto una pianta molto apprezzata nei grandi giardini e parchi e lungo i viali. Un noto esempio è il viale “Unter den Linden” (letteralmente “sotto i tigli”), ubicato a Berlino e voluto dal duca Federico Guglielmo di Brandeburgo nel 1647 per ombreggiare la strada che abitualmente percorreva partendo dalla sua residenza urbana per raggiungere il Tiergarten, ovvero il parco di caccia.
5. Zelkova carpinifolia (Olmo del Caucaso)
Albero a foglia caduca originario del Caucaso, e di alcune zone dell’Iran. Il genere comprende solo 6 specie e appartiene alla famiglia delle Ulmaceae, alla quale appartiene anche il genere Ulmus. Pare sia stato introdotto in Francia, a scopi ornamentali, intorno al 1760. L’epiteto specifico (carpinifolia) indica la somiglianza delle sue foglie con quelle del carpino. Quest’albero è forse d’impianto ottocentesco, un altro esemplare è presente nel giardino della reggia ducale di Colorno, fatto piantare da Maria Luigia, duchessa di Parma, nel corso della prima metà dell’Ottocento.
6. Carpinus betulus (Carpino bianco)
E’ un albero a foglia caduca diffuso, allo stato spontaneo, in un vasto areale che si sviluppa dall’Europa al Caucaso. Caratterizza, insieme alla farnia (Quercus robur = Q. peduncolata), il paesaggio della Pianura Padana sin dalla Preistoria (indicativamente 7-6.000 anni avanti Cristo) tanto che la formazione prende il nome di Querco-carpineto. Generalmente, in autunno, sebbene secche, le foglie restano attaccate alla pianta e cadono alla ripresa vegetativa. E’ diffusa in tutta Italia ad eccezione delle isole (Sicilia e Sardegna). E’ stata utilizzata per creare siepi campestri in quanto si adatta bene alla potatura regolare. Probabilmente il nome della città di Carpi deriva proprio da questo albero (latino “carpinus”) tanto che è raffigurato nello stemma cittadino.
7. Pinus sylvestris (Pino silvestre)
Si tratta di una conifera sempreverde presente allo stato spontaneo in un areale vastissimo che comprende le zone fredde e temperato-fredde dall’Europa al Giappone (Eurasia). In Italia è presente, in natura, nelle regioni settentrionali e in Sicilia. Gli aghi del pino silvestre hanno proprietà balsamiche, espettoranti, diuretiche e antisettiche. Il legno delle piante che vivono a nord delle Alpi è di buona qualità e viene impiegato in falegnameria e per la produzione di pali.
8. Taxus baccata (Tasso, Albero della morte)
E’ un albero sempreverde che può raggiungere 15-23 m di altezza. Allo stato spontaneo vive in un vasto areale che va dall’Europa all’Asia. In Italia è presente in tutte le regioni, anche se solitamente raro, ed è tipico della fascia montana temperata, compresa tra i 300 e i 1.600 m di altitudine. Pianta molto longeva, può vivere sino a circa 2.000 anni ed è un relitto dell’epoca Terziaria (o Cenozoica). Il nome del genere deriva dal greco “taxos”, latino “taxus”, cioè arco, in quanto quest’ultimi, sin dall’antichità, si fabbricavano col suo legno elastico e resistente. Le foglie e i semi sono velenosi, da cui il nome di albero della morte, mentre l’involucro del seme, l’arillo, è appetito dagli uccelli che ne favoriscono la propagazione. Molto utilizzato nei giardini poiché ben sopporta la potatura e si presta per realizzare siepi e figure geometriche.
9. Acer negundo ( Acero americano, Negundo)
L’acero americano è un albero a foglia caduca originario dell’America settentrionale. La prima introduzione in Europa risale al 1688, anno in cui risulta vegetare nel giardino Fulham, in Inghilterra. Nel 1690 compare in Olanda e nel 1699 in Germania. In Italia è stato segnalato per la prima volta nel 1780. A motivo della sua rapida crescita è stato utilizzato in giardini, parchi, viali alberati.
10. Acer campestre (Acero campestre)
Albero a foglia caduca diffuso, allo stato spontaneo in Europa fino al Caucaso, in Italia è presente in tutte le regioni. in Pianura padana è associato ai querceti. Utilizzato in passato per la formazione di siepi campestri, ha una buona resa calorica. E’ una pianta mellifera, le cui foglie venivano utilizzate come foraggio per il bestiame e, non essendo molto vigoroso, veniva utilizzato come tutore vivo della vite nel sistema della piantata.
11. Buxus sempervirens (Bosso, Mortella, Bossolo)
Arbusto sempreverde, il suo areale è prevalentemente mediterraneo. Caratterizzato da una crescita lenta, ha un legno molto compatto e duro e per questo motivo veniva impiegato, sin dall’antichità, per realizzare scatole e strumenti a fiato. E’ molto longevo e ben sopporta la potatura, tanto che fu impiegato, a partire dai Romani, per realizzare siepi e forme geometriche zoomorfe e antropomorfe.
12. Crataegus monogyna (Biancopsino, Spino bianco)
Piccolo albero o grande arbusto a foglia caduca, è diffuso allo stato spontaneo in un ampio areale che va dall’Europa al Giappone (euro-asiatico). In Italia è presente in tutte le regioni. A causa di una malattia, il colpo di fuoco batterico, in Emilia Romagna è vietato piantarlo per evitare che la batteriosi possa essere trasmessa anche alle piante da frutto che appartengono alla stessa famiglia (pero e melo). Veniva ampiamente utilizzato per formare le siepi campestri che, grazie alle sue spine, erano difficilmente valicabili. In alcuni siti neolitici sono stati rinvenuti semi di biancospino, il che induce a pensare che i suoi piccoli frutti venissero usati nell’alimentazione umana. E’ pianta mellifera e ha numerose proprietà medicinali.
13. Platanus x acerifolia (Platano comune)
Questo platano, che raggiunge un’altezza di 20-30 m, deriverebbe, secondo alcuni autori, dall’incrocio casuale tra Platanus orientalis e Platanus occidentalis. Dove sia avvenuto questo incrocio non è certo: vi è chi sostiene che il paese d’origine sia la Spagna, tesi supportata dal suo sinonimo, Platanus x hispanica; altri autori, invece, attribuiscono a John Tradescant il giovane, celebre botanico e giardiniere, la “scoperta” di questa nuova specie ibrida, avvenuta intorno alle metà del ‘600 nel suo vivaio sito nel borgo londinese di Lambeth. Questo albero, in effetti, è anche conosciuto col nome di “London plane” (Platano di Londra). La specie in questione fu estesamente piantata a Londra e si diffuse in molte città europee in quanto resistente alle condizioni urbane. E’ stata ampiamente utilizzata anche nel corso del ‘900 per alberare i viali di molte città italiane.
14. Juglans nigra (Noce americano)
Albero di grandi dimensioni, a foglia caduca, originario dell’America nord orientale. E’ documentato in Italia a partire dal 1760 e fu introdotto per essere utilizzato nei giardini e per produrre legno di pregio, duro, omogeneo. Infatti in America veniva e viene tuttora utilizzato per i mobili, i calci dei fucili e in ebanisteria. In Europa, invece, la qualità del legno delle piante coltivate è di gran lunga inferiore per cui, alle lunga, ha prevalso l’impiego ornamentale. Le noci sono commestibili, ma la parte edule è molto limitata e di gusto non particolarmente gradevole.
15. Juglans ailantifolia (Noce giapponese)
Albero a foglia caduca, di circa 20 m di altezza, originario del Giappone e della più grande isola russa Sakhalin, situata a nord del Giappone. Introdotto in Europa sul finire dell’Ottocento, è menzionato nella Revue Horticole pubblicata a Parigi nel 1878. Non è noto l’anno d’introduzione in Italia. L’epiteto specifico (ailantifolia) evidenzia il fatto che le foglie di questa specie ricordano quelle dell’ailanto (Ailanthus altissima). In Europa è impiegato come albero ornamentale. Le noci sono commestibili.
16. Ulmus minor (Olmo comune, Olmo campestre)
Albero a foglia caduca che cresce spontaneo nel vasto areale che comprende l’Europa e il Caucaso. In Italia è presente in tutte le regioni. Specie diffusa nei boschi planiziali del nord Italia, era utilizzato nei giardini barocchi dell’Emilia insieme all’acero campestre, per realizzare le siepi a contorno dei boschetti (bosquets), come tutore vivo della vite nel sistema della piantata, per formare la lettiera al bestiame in stalla e per le siepi campestri. Un tempo molto diffuso nelle campagne emiliane, ha subito una drastica riduzione a causa dell’insorgenza di una malattia fungina introdotta in Italia negli anni ’20 del Novecento.
17. Taxodium distichum (Cipresso calvo, Cipresso delle paludi)
Albero a foglia caduca originario degli Stati Uniti sud orientali. Ama vivere nei terreni umidi, prossimi a bacini idrici o direttamente nei terreni paludosi. E’ una pianta longeva con chioma di forma piramidale. E’ stato citato per la prima volta, in Italia, nel 1760 da Carlo Ludovico Allioni. La specie è utilizzata in ambito ornamentale in prossimità di terreni umidi e laghi. E’ chiamato cipresso calvo in quanto, al contrario del cipresso nostrano che è sempreverde, questo perde le foglie in autunno, le quali, prima di cadere, assumono una bellissima colorazione dal giallo al rosso.
18. Sophora japonica (Sofora del Giappone)
Albero a foglia caduca originaria del Giappone e della Cina, raggiunge 20-25 m di altezza. E’ stata introdotta in Europa come pianta ornamentale da Pierre Nicolas Le Chéron d’Incarville, un gesuita missionario in Cina, appassionato di botanica, che inviò al Jardin des plantes di Parigi specie fino ad allora sconosciute in Europa. Tra queste nel 1747 spedì Sophora japonica (ora classificata come Styphnolobium japonicum) e Koelreuteria paniculata, nel 1751 Ailanthus altissima e fu il primo a menzionare il kiwi. In Italia la sofora viene citata per la prima volta nel 1799 da Attilio Zuccagni che ricoprì l’incarico di direttore dell’Orto Botanico di Firenze.
19. Quercus robur (Farnia)
Nota anche col sinonimo di Quercus peduncolata, è la quercia tipica delle foreste planiziali dell’Europa centrale e orientale. In Italia è presente allo stato spontaneo in tutte le regioni ad eccezione della Sicilia. Specie tipica dei boschi della pianura padano-veneta, vegeta laddove vi è buona disponibilità di acqua, con falda freatica superficiale. Il pregiato legno è impiegato per la realizzazione di pavimenti, mobili, e botti. Le ghiande venivano utilizzate per l’alimentazione dei maiali.
20. Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)
Albero a foglia caduca è specie di origine eruopeo-caucasica. E’ presente in tutte le regioni italiane, ad eccezione della Basilicata. Predilige suoli profondi, non compatti e freschi ove può raggiungere 40 m di altezza. Il frassino era considerato, dalle antiche popolazioni del nord Europa, una pianta sacra e gli si attribuiva la capacità di allontanare gli spiriti malvagi. Il legno tenace ed elastico lo ha reso ottimale per la realizzazione di manici per martelli, picconi e badili. Inoltre è stato impiegato per i telai degli aerei della prima guerra mondiale, gli sci, le carrozzerie delle automobili, le sedute dei treni e i carri agricoli.
—
Ricerca storica e testo a cura del dott. agr. Eraldo Antonini
Progetto e grafica a cura del dott. agr. Eraldo Antonini e dell’arch. Angelo Silingardi Seligardi
Foto di Michele Sensi
Acquerelli dell’artista Monica Bonvicini